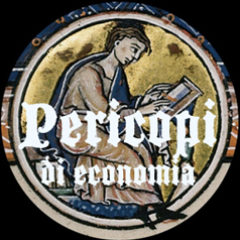Quello dell’istruzione e’ l’unico settore della societa’ italiana in cui la produttivita’ e’ in costante diminuzione da oltre mezzo secolo.
Che cos’e’ la produttività dell’istruzione?
Una definizione informale ma intuitivamente chiara e’ la seguente: la produttivita’ e’ l’inverso del numero di anni necessari per raggiungere un determinato grado di organizzazione mentale.
Supponiamo di assumere, come metro, il livello di organizzazione mentale – conoscenze, padronanza del linguaggio, capacita’ logiche – di un diplomato di terza media del 1962, l’ultimo anno prima dell’introduzione della scuola media unica. A lui erano occorsi otto anni di studio per raggiungere quel livello. Quanti ne occorrono oggi per raggiungere un livello comparabile? […]
Ognuno avra’ la sua risposta, la mia ad esempio
e’ che per ottenere quel livello di organizzazione mentale oggi siano necessari da un minimo di cinque anni in piu’ (se si e’ frequentato un buon liceo classico) a un massimo di tredici anni in piu’ (se occorre addirittura un dottorato di ricerca per recuperare pessimi studi precedenti). E se proprio devo buttare li’ un numero, giusto per fissare le idee, direi che otto anni in piu’, rispetto agli otto anni necessari a conseguire la licenza media, e’ gia’ una stima piuttosto benevola dell’abbassamento della produttivita’ dell’istruzione intervenuto negli ultimi cinquant’anni, dalla fine degli anni sessanta a oggi […]
Insomma: in mezzo secolo la produttivita’ dell’istruzione e’, come minimo, dimezzata […]
L’ingente massa di tempo libero regalata dall’aumento della produttivita’ del lavoro non e’ stata usata per innalzare il livello culturale delle persone, la loro sensibilita’ artistica, la loro capacita’ di vivere in modo saggio, piacevole e salutare.
Specie in Italia, dove anche i livelli di istruzione formale sono rimasti bassissimi, il maggiore tempo a disposizione e’ stato impiegato essenzialmente per ampliare lo spettro dei consumi.
Anziche’ usare la cultura per riempire il tempo libero, si e’ scelto di usare i consumi per “attrezzarlo” […]
Di qui l’impressionante sviluppo di beni, servizi e attivita’ il cui scopo primario e’ di aiutarci a “consumare tempo libero”: iPod per la musica, iPad per Internet, smartphone un po’ per tutto, dai messaggi alle foto agli acquisti online; ristoranti, bar, pub, piadinerie, focaccerie, bistrot, paninoteche, gelaterie, tavole calde piu’ o meno etniche, wine store, cocktail bar, sushi bar; spa, palestre, massaggi, centri yoga; corsi di meditazione, cucina, ballo afroamericano, break dance; acquisti online, mercatini dell’usato, mercatini dell’artigianato; maghi alle feste dei bambini, animatori nei villaggi turistici; fiere del formaggio, del risotto, del tartufo, del cioccolato; concerti in piazza, festival di ogni genere e specie, spettacoli all’aperto, megaschermi per gli eventi sportivi e musicali; senza dimenticare l’ampio mondo delle discoteche e dei locali in cui si beve, si ascolta musica, si balla (e qualche volta si sballa) […]
Il tempo libero che il progresso tecnologico ci ha regalato non solo non e’ di tutti, ma e’ inestricabilmente intrecciato al consumo.
Info:
https://luz.it/spns_article/intervista-luca-ricolfi-societa-signorile-massa/
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/01/05/ricolfi-signorile-massa/
https://sbilanciamoci.info/societa-signorile-di-massa-o-societa-signorile-e-basta/