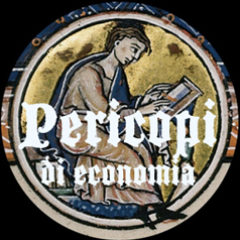Delle questioni che rimangono sempre nell’ombra – per quanto riguarda le diseguaglianze – e’ quella del fisco. Se ne parla solo per dire che si pagano troppe tasse, mai che i ricchi pagano poche tasse […]
«Nel 1970 gli americani piu’ ricchi versavano al fisco oltre il 50% del proprio reddito, cioe’ il doppio di quanto versavano i lavoratori. Nel 2018, dopo la riforma di Trump, i miliardari hanno versato meno tasse di metalmeccanici, insegnanti, pensionati».
Nel corso di alcuni decenni, le aliquote sui redditi piu’ alti (in quasi tutto il mondo, anche negli Stati Uniti) sono passate da oltre il 90% a mediamente il 40%; le imposte di successione in molti Paesi sono state abolite o ridotte al minimo (negli Stati Uniti il gettito fiscale dell’imposta di successione si e’ ridotto di quattro volte); l’imposta patrimoniale e’ un tabu’: tutti favori ai privilegiati e ai ricchi, tutta benzina sul fuoco delle diseguaglianze […]
Il tema delle diseguaglianze e’ strettamente collegato a quello della mobilita’ sociale.
I ricchi che abbiamo intervistato raramente individuano nella distorsione del modello dello sviluppo economico liberista di questi trent’anni la ragione principale della crescita delle disuguaglianze.
Molti danno la colpa all’assenza di crescita economica, alla globalizzazione, al mancato riconoscimento delle competenze e del merito, all’istruzione di bassa qualita’, alla scarsa propensione dei nostri giovani a studiare le materie tecnologiche e scientifiche, all’inveterata abitudine italica di privilegiare la cooptazione, l’affiliazione politica, lo sfruttamento delle reti di relazioni acquisite.
L’ascensore sociale si sarebbe fermato per questi motivi, e non per il carattere strutturale di politiche economiche che rendono le diseguaglianze crescenti e croniche […]
Pochissimi (tra questi: Farinetti, con l’imposta di successione, e Profumo, con la proposta di patri- moniale) citano lo strumento fiscale, la possibilita’ di una tassazione piu’ progressiva e la redistribuzione della ricchezza come strumenti decisivi per ridurre le disuguaglianze.
Molti pensano che i soldi delle tasse vengano spesi male, e che quindi valga la pena ridurle.
Capitalismo/Marcon
Se la classe inferiore sapesse. Ricchi e ricchezze in Italia – Giulio Marcon – People (2023)